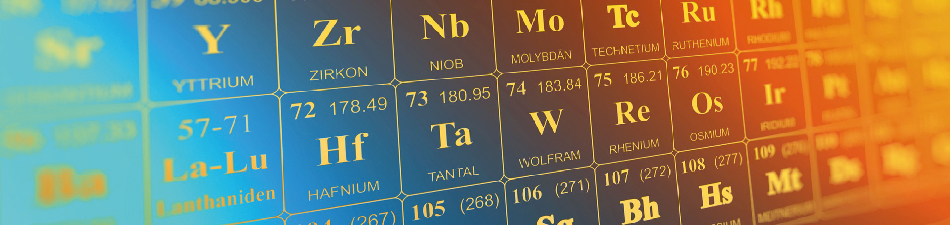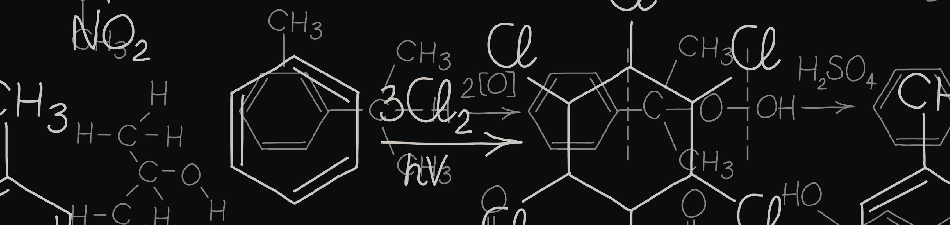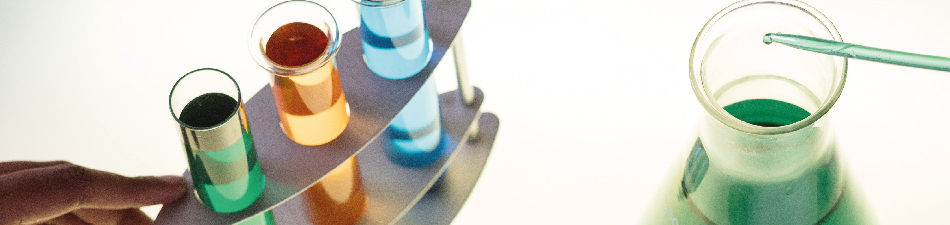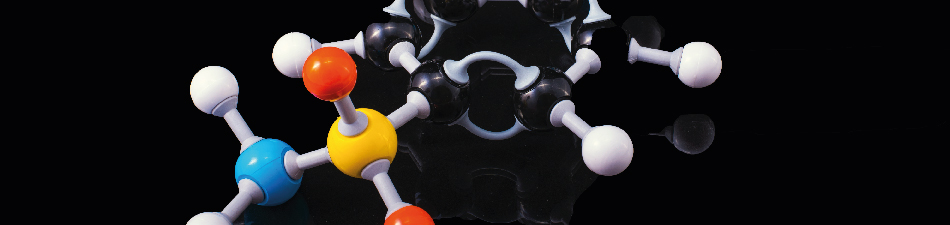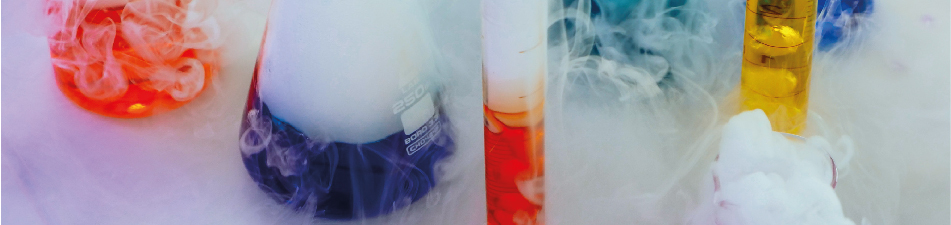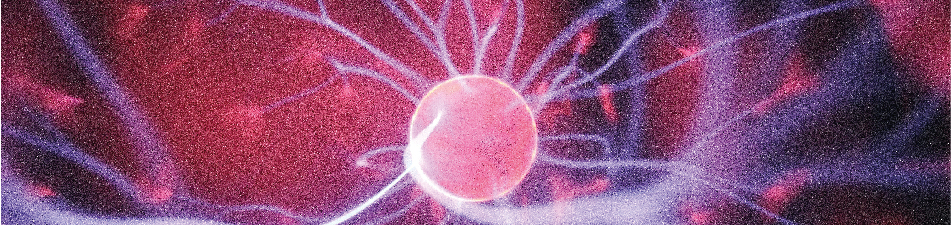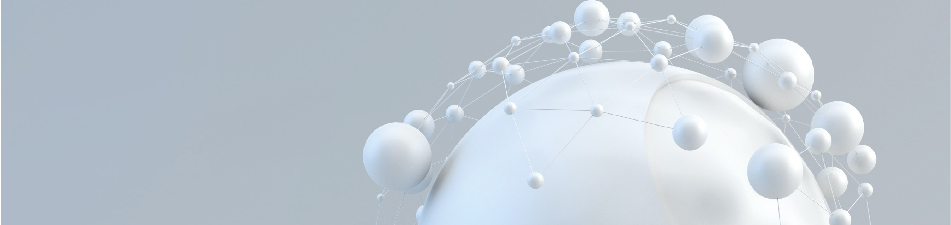Feed aggregator
Hydrophobic and mechanically reinforcing coatings from palmitoylated lignin via waterborne spraying
DOI: 10.1039/D5GC05423K, Paper
 Open Access
Open Access    This article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported Licence.Jie Wu, Nathan Huang, Daniel Barker-Rothschild, Zhangmin Wan, Minke Yang, Xin Shu, Yi Hu, Joshua Booth, Oliver Evenden, Orlando J. Rojas, Kwang Ho Kim
  This article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported Licence.Jie Wu, Nathan Huang, Daniel Barker-Rothschild, Zhangmin Wan, Minke Yang, Xin Shu, Yi Hu, Joshua Booth, Oliver Evenden, Orlando J. Rojas, Kwang Ho KimPalmitoylation of lignin imparts strong hydrophobicity and flexibility, enabling waterborne spray coatings with durable water repellency and enhanced wet strength, offering a sustainable route for paper protection and packaging.
To cite this article before page numbers are assigned, use the DOI form of citation above.
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
Aluminum–graphite dual-ion batteries: recent advances and challenges
DOI: 10.1039/D5GC05069C, Critical Review
 Open Access
Open Access    This article is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported Licence.Hui Shi, Anastasia A. Teck, Laura Lander, Maria-Magdalena Titirici
  This article is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported Licence.Hui Shi, Anastasia A. Teck, Laura Lander, Maria-Magdalena TitiriciThis review highlights advances and remaining challenges in aluminum–graphite dual-ion batteries (AGDIBs), covering progress in electrodes, electrolytes, and system design and offering insights to guide development of greener battery technologies.
To cite this article before page numbers are assigned, use the DOI form of citation above.
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
Adsorption-supported ozonation of complex mariculture wastewater pharmaceuticals using a greener (Ni/Fe–C) nano-composite derived by co-pyrolysis of coconut shell and partially reduced iron: mechanism and implications
DOI: 10.1039/D5GC05065K, Paper
 Open Access
Open Access    This article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported Licence.Muhammad Noman, Guangwei Yu
  This article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported Licence.Muhammad Noman, Guangwei YuUndeniably, intensive utilization of emerging antibiotics like oxytetracycline (OTC) and other complex pharmaceuticals in mariculture poses an ecological threat.
To cite this article before page numbers are assigned, use the DOI form of citation above.
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
Photo-coupled electrocatalytic conversion of CO2 to CO over cobalt phthalocyanine-modified POM-K8Ta6O19 Z-scheme photocathodes
DOI: 10.1039/D5GC04093K, PaperChen Liu, Linjie Song, Wanwan Wu, Haiyan Li, Dongbin Dang, Yan Bai
The construction of an organic–inorganic Z-scheme heterojunction photocathode was accomplished through a straightforward impregnation calcination method, which has been demonstrated to be efficacious in the reduction of CO2 to CO.
To cite this article before page numbers are assigned, use the DOI form of citation above.
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
Lignin-based non-isocyanate polyurethanes: towards sustainable polyurethanes
DOI: 10.1039/D5GC04066C, Critical ReviewPeter K. Karoki, Christian O. Kemefa, Xianzhi Meng, Yunqiao Pu, Mairui Zhang, Soyeon Jeong, Chang Geun Yoo, Arthur J. Ragauskas
This review highlights recent advances in lignin valorization for the sustainable synthesis of non-isocyanate polyurethanes (NIPUs), emphasizing on green routes, structural modifications, and emerging applications in bio-based materials.
To cite this article before page numbers are assigned, use the DOI form of citation above.
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
Interface-engineered, multifunctional wood composites via recyclable solvent processing for ultra-durable triboelectric energy harvesting
DOI: 10.1039/D5GC03667D, PaperJiaqi Liao, Wenwen Zhu, Shitao Shi, Zewei Ye, Chencong Liu, Haomeng Yu, Qingfeng Sun, Julia L. Shamshina, Xiaoping Shen
A recyclable-solvent IL method enables dense MOF growth on wood, creating durable composites for stable, high-performance triboelectric energy harvesting.
To cite this article before page numbers are assigned, use the DOI form of citation above.
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
A strategy of H-bond confinement catalysis for efficient degradation of polyethylene glycol into glycol diester over OH-functionalized ionic liquid
Green Chem., 2025, Accepted Manuscript
DOI: 10.1039/D5GC05259A, PaperXiaoqian Chang, Yunpeng Xu, Chun-Liang Hou, Ruihan Wang, Xiaoyang Chang
Upgrading plastic waste into high-value chemicals and achieving recycling is of great significance for sustainable development. Herein, we report a green, mild, solvent- and metal-free catalytic approach that uses hydroxyl-functionalized...
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
DOI: 10.1039/D5GC05259A, PaperXiaoqian Chang, Yunpeng Xu, Chun-Liang Hou, Ruihan Wang, Xiaoyang Chang
Upgrading plastic waste into high-value chemicals and achieving recycling is of great significance for sustainable development. Herein, we report a green, mild, solvent- and metal-free catalytic approach that uses hydroxyl-functionalized...
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
Simple fabric-to-fibre recycling of PBT/cotton textile blends using water under mild conditions
DOI: 10.1039/D5GC03705K, PaperSimão V. Pandeirada, Paula S. S. Lacerda, Michael A. R. Meier, Andreia F. Sousa
A water-based, mild process enables efficient recycling of polyester/cotton textile blends under ambient conditions, achieving over 94% fibre recovery and preserving fibre integrity for circular textile applications.
To cite this article before page numbers are assigned, use the DOI form of citation above.
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
Recycling of spent lithium-ion batteries via the hydrothermal process
DOI: 10.1039/D5GC04598C, Critical ReviewYafei Shen
This review summarizes advances and challenges in hydrothermal regeneration and hydrothermal leaching for valuable metal recovery from spent lithium-ion batteries.
To cite this article before page numbers are assigned, use the DOI form of citation above.
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
Green conversion of spent lithium-ion batteries via infrared pyrolysis: gas-assisted metal recovery and reaction pathway elucidation
DOI: 10.1039/D5GC05022G, PaperMoshan Li, Zuohua Liu, Erfeng Hu, Guangwen Xu, Jianglong Yu, Dean Pan, Youcai Ma, Rui Qu
The recycling of waste lithium-ion batteries (LIBs) plays a pivotal role in the sustainable advancement of renewable energy technologies.
To cite this article before page numbers are assigned, use the DOI form of citation above.
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
Peculiar even-odd effect in semi-crystalline poly(alkylene succinate)s with a wide range of repeating unit chain lengths
DOI: 10.1039/D5GC05522A, PaperJuan Torres-Rodríguez, Antxon Martínez de Ilarduya, Haritz Sardon, Ricardo A. Pérez-Camargo, Alejandro J. Müller
A green bulk polymerization enables access to a polysuccinate series (2–12 CH2) and reveals an even–odd effect that diminishes but never completely disappears, consistently influencing crystallization behavior and molecular packing.
To cite this article before page numbers are assigned, use the DOI form of citation above.
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
Electroenzymatic cascade synthesis of chiral α-substituted aromatic halohydrins from alkenes: a green and stereoselective approach
DOI: 10.1039/D5GC04446D, PaperYihang Dai, Chenyi Zhang, Xinjia Yu, Chuang Du, Fengxi Li, Lei Wang
Herein, we report an electroenzymatic cascade synthesis strategy for alkenes, achieving the efficient conversion of alkenes into chiral α-substituted aromatic halohydrins with excellent yields and enantioselectivities within a single reaction system.
To cite this article before page numbers are assigned, use the DOI form of citation above.
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
Electrochemical sulfonylation with sulfur dioxide: a sustainable strategy for organic synthesis
DOI: 10.1039/D5GC04193G, Tutorial ReviewZhi-Long Lei, Hai-Tao Tang, Ying-Ming Pan
This review summarizes strategies, mechanisms, and applications of using sulfur dioxide as a sulfur source to construct C–S bonds via electrochemistry for synthesizing sulfonate esters and other high-value products.
To cite this article before page numbers are assigned, use the DOI form of citation above.
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
An electrolyte additive enabling dual kinetic regulation for stable zinc anodes in aqueous zinc batteries
DOI: 10.1039/D5GC04716A, PaperHuidi Shi, Yiqun Du, Liu Yang, Bingying Sun, Ximing Yu, Anbin Hu, Shuhua Yang, Jinkai Li, Bingqiang Cao
A green electrolyte design weakens the adsorption of the proton intermediate, delays Sand's time, and increases the nucleation rate, enabling dual anode kinetics and improving zinc anode stability.
To cite this article before page numbers are assigned, use the DOI form of citation above.
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
Chemical recycling of polycarbonate waste into advanced aviation fuel candidates via nickel-oxygen vacancy dual sites
Green Chem., 2025, Accepted Manuscript
DOI: 10.1039/D5GC04561D, PaperYushuang Huang, Jiawei Xie, Yisong Zhou, Qianqian Song, Yuan Lei, Chang-An Zhou, Chao Wang, Kui Ma, Lei Song, Hairong Yue, Ji-Jun Zou
Transforming polycarbonate (PC) waste to C15 dicycloalkane offers a green pathway for plastic recycling and advanced aviation fuel production. Conventional metal-zeolite catalysts rely on noble metals and suffer from diffusion...
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
DOI: 10.1039/D5GC04561D, PaperYushuang Huang, Jiawei Xie, Yisong Zhou, Qianqian Song, Yuan Lei, Chang-An Zhou, Chao Wang, Kui Ma, Lei Song, Hairong Yue, Ji-Jun Zou
Transforming polycarbonate (PC) waste to C15 dicycloalkane offers a green pathway for plastic recycling and advanced aviation fuel production. Conventional metal-zeolite catalysts rely on noble metals and suffer from diffusion...
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
Upcycling the Lithium Extraction By-products from Spent Lithium-ion Batteries into High-voltage Polyanionic LiMnxFe1-xPO4
Green Chem., 2025, Accepted Manuscript
DOI: 10.1039/D5GC03642A, PaperFan Xiao, Lehan Zhu, Zhangjun Wu, Haotian Zhu, Juan Xia, Jiannan Zhu, Zeheng Yang, Weixin Zhang
Lithium iron phosphate (LiFePO4, LFP) and lithium manganese oxide (LiMn2O4, LMO) batteries dominate the energy storage market due to their superior safety, thermal stability, and cost-effectiveness compared to nickel-cobalt-manganese (NCM)...
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
DOI: 10.1039/D5GC03642A, PaperFan Xiao, Lehan Zhu, Zhangjun Wu, Haotian Zhu, Juan Xia, Jiannan Zhu, Zeheng Yang, Weixin Zhang
Lithium iron phosphate (LiFePO4, LFP) and lithium manganese oxide (LiMn2O4, LMO) batteries dominate the energy storage market due to their superior safety, thermal stability, and cost-effectiveness compared to nickel-cobalt-manganese (NCM)...
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
Exploring the Environmental and Economic Performance of Fluorinated Intermediates in Pesticide Manufacturing: Life Cycle Assessment Perspective
Green Chem., 2025, Accepted Manuscript
DOI: 10.1039/D5GC04729C, PaperYunzhi Zhao, Tianzuo Zhang, Jinglan Hong, Ruiqi Jin, Xiaotian Ma
Fluorinated intermediates have become critical components in modern pesticide manufacturing, with fluorinated varieties accounting for more than half of recent pesticide approvals amid 70% global consumption growth. However, systematic quantification...
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
DOI: 10.1039/D5GC04729C, PaperYunzhi Zhao, Tianzuo Zhang, Jinglan Hong, Ruiqi Jin, Xiaotian Ma
Fluorinated intermediates have become critical components in modern pesticide manufacturing, with fluorinated varieties accounting for more than half of recent pesticide approvals amid 70% global consumption growth. However, systematic quantification...
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
Solvent-induced microstructure disruption and catalytic activation synergy toward mild and rapid degradation of epoxy thermosets
DOI: 10.1039/D5GC04437E, PaperKe Li, Xu Zhao, Dongchu Liu, Weifeng Jia, Qiang Peng
Co-solvent hydrogen bonding interactions facilitate mild and rapid degradation of epoxy thermosets, with the degradation products capable of being reconstituted into recyclable polymers.
To cite this article before page numbers are assigned, use the DOI form of citation above.
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
Ion-Pair as a Superacidic Precatalyst for the Synthesis of Indole Alkaloids: A Novel Entry into the Fischer Indole Synthesis
Green Chem., 2025, Accepted Manuscript
DOI: 10.1039/D5GC04707B, PaperPooja Sivaganesan, Chibisree Elanchezhian, Diksha Bansal, Mrinal Kanti Das, Saikat Chaudhuri
We report the first application of Ion-pair catalysis to the Fischer indole synthesis, enabling efficient construction of structurally diverse indole frameworks under mild conditions. Using the [Ph₃C]⁺[B(C₆F₅)₄]⁻ ion pair as...
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
DOI: 10.1039/D5GC04707B, PaperPooja Sivaganesan, Chibisree Elanchezhian, Diksha Bansal, Mrinal Kanti Das, Saikat Chaudhuri
We report the first application of Ion-pair catalysis to the Fischer indole synthesis, enabling efficient construction of structurally diverse indole frameworks under mild conditions. Using the [Ph₃C]⁺[B(C₆F₅)₄]⁻ ion pair as...
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
Assessments of life cycle and biodegradation properties uncovered distinct profiles of pharmaceutical excipients guiding selection for drug formulations
DOI: 10.1039/D5GC02518D, PaperMila Bading, Evan Griffing, Oliver Olsson, Jake Harris, Jochen Scher, Atsushi Sakurai, Michael Overcash, Klaus Kümmerer
Urgent sustainability efforts are needed, particularly in resource-intensive industries such as the pharmaceutical sector.
To cite this article before page numbers are assigned, use the DOI form of citation above.
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry